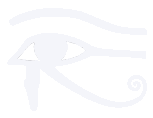Le Virgole, un appuntamento estemporaneo fra chi ama scrivere e chi ama leggere.
La prima cosa che vedo è la mia mano destra appoggiata sul bordo del lenzuolo. È segnata da sottili scorticature, come spruzzi geometrici di sabbia su tutta la superficie, dal polso fino all’attaccatura delle dita. Forse mi sono sbucciato con una lama delle forbici, o forse la pelle si è graffiata per colpa delle unghie di quella signora che cercava di trattenermi mentre tagliuzzavo i fogli di carta impilati sulla scrivania del grande capo.
Guardo fuori dalla finestra e mi rendo conto che il cielo è carico di nuvole. Dovrò darmi da fare se le vorrò contare tutte, perché la luce è già calata, e presto tutto sarà scuro.
Non so bene dove mi trovo, ma capisco che mi hanno portato via dal palazzo di vetro. Sono sdraiato e ho le mani legate alla spalliera del letto. Mi fanno delle domande a cui non rispondo. Forse le mie corde vocali si sono spezzate quando ho urlato contro tutti, senza ritegno.
Come andiamo, Guido? Come ti senti? Hai sete, fame, bisogno di riposo?
Devo averla fatta grossa riducendo a pezzi tutti quei tabulati pieni di numeri e parole senza senso. Li facevo volare come coriandoli, suscitando sgomento tra i colleghi. La mia cartellina colorata, invece, è rimasta intonsa sulla scrivania del grande capo. Spero che a quest’ora qualcuno ne avrà letto il contenuto. Si, mi auguro che almeno una volta in trent’anni qualcheduno si sarà degnato di esaminare i miei scritti, dopo 365 dannate pagine di 30 calendari, cioè 10.950 volte in cui ho subito l’umiliazione di vedere cestinato il mio lavoro, senza che gli venisse dedicato neppure uno sguardo.
Fate trascorrere a un uomo qualunque un certo numero di anni in uno stato di continua frustrazione e lo ritroverete disorientato nell’affrontare la vita quanto un frate costretto a vivere dentro un bordello. Con l’aggravante che, mentre il frate ha la fede che lo sostiene, l’uomo qualunque è completamente impreparato di fronte a simili scherzi del destino.
Ho bisogno di chiudere gli occhi. Sento le loro voci e il flebile eco delle mie parole che erompono dalla gola con fatica:
Lasciamolo tranquillo, sembra assopito, dicono.
Perfetto, era quello che desideravo, rispondo.
Parla nel sonno, aggiungono.
Poveri ingenui (questo non so se lo dico o lo penso).
Erano ricche di spunti le mie cartelline colorate. Contenevano ritagli di quotidiani incollati su fogli di formato A4. In alto a destra c’era il numero totale delle parole di ogni pagina, che doveva essere pari alle lettere che componevano la frase finale, scritta a mano, in fondo a ciascun foglio. Ci voleva molto ingegno per assicurare la coerenza del tutto, eppure nessuno ha mai preso in considerazione il mio acume, perché le carte venivano cestinate senza essere lette. Il grande capo non ha voluto apprezzare la saggezza delle parole che scrivevo, fedeli alla regola del numero e inneggianti alla rotondità dell’animo umano. Ricordo con dolore il suo sbigottimento e le sue parole oltraggiose, che mi piombavano addosso come sassi.
Povero Guido, ecco un’altra raccolta di ritagli! Non si capisce perché incolli pezzi di giornale per comporre frasi. E cosa dire delle banalità che scrive a fondo pagina? E il numero in alto a destra? Che follia!
Sapendo che il mio lavoro veniva sistematicamente cestinato, prima di consegnarlo al grande capo mi avviavo verso la macchina fotocopiatrice, inserivo tutto nello scompartimento giusto e digitavo il numero cento. Certo che avete capito bene! facevo cento fotocopie di ogni cartellina e poi le distribuivo su tutte le scrivanie del palazzo di vetro. Poi pigiavo i tasti per la funzione di scanner, facevo una copia elettronica del contenuto della cartellina e inviavo il file a tutti i colleghi, via e-mail. Questo scrupoloso impegno quotidiano mi aveva fatto guadagnare l’appellativo di “vomitacarte”. Non mi piaceva affatto l’epiteto, e di certo non era l’unica cosa che mi faceva patire, al palazzo di vetro. Ho odiato tutto, alla fine.
Devo averla fatta grossa quando l’uomo della sicurezza ha cercato di bloccare il mio impeto e ho reagito sferrando cazzotti alla rinfusa e colpendolo con la punta delle forbici. Ero arrivato a cinquantacinque anni senza mai compiere gesti inconsulti. Incassavo il dolore e non avevo il coraggio di aggredire. Alla fine sono esploso, senza che nessuno riuscisse a trattenermi:
No, Guido, non lo fare! Imprecavano.
Vi ammazzo tutti! Gridavo.
Stai calmo, cerchiamo di evitare che finisca male, ripetevano.
Prima distruggo le vostre insulse carte e poi vi uccido uno a uno, urlavo ancora più forte.
Stai fermo, Guido, imploravano ancora.
Fanculo! Strillavo a squarciagola.
Molla le forbici! Minacciavano.
E perché mai dovrei farlo? Balbettavo piangendo, con la rabbia che veniva fuori a singhiozzi.
Non credo di averlo ucciso, ma di certo l’ho ferito a sangue. Sono rimasti tutti terrorizzati fino all’arrivo dei due poliziotti che mi hanno immobilizzato. È stato bello scorgere il panico sui volti dei colleghi mentre continuavo a minacciarli con le forbici.
Al palazzo di vetro mi avevano isolato perché la mia andatura saltellante li metteva a disagio e probabilmente trovavano ripugnante il fatto che mi grattavo continuamente le tempie e rosicchiavo le unghie dopo avere schiacciato con i polpastrelli il cioccolatino che mi regalava la mamma tutte le mattine, prima che io prendessi il tram per raggiungere il palazzo di vetro. Ma soprattutto doveva apparire assai ridicolo il fatto che mi veniva da camminare raso muro per evitare il più possibile di dare le spalle a chi incontravo. Non ho mai capito perché si ritiravano tutti nelle loro stanze sghignazzando quando attraversavo il corridoio con la schiena aderente alle pareti. Mi ferivano nel profondo con i loro commenti pungenti:
Povero vomitacarte, chissà cosa gli è successo… Avrà subito un trauma … Si copre le spalle, è un gesto di difesa… Cosa fa con quei cioccolatini? Che schifo! E le sue cartelline? Chissà cosa c’è dentro! Nessuno le ha mai aperte, compreso il grande capo, che prova ribrezzo solo all’idea di toccarle. Le fa cestinare dalla sua assistente ….
Ho odiato quasi subito quell’impiego da addetto alla contabilità ottenuto non so come. Il giorno dell’assunzione avevo venticinque anni e dovevo apparire assai strano con il vestito classico che la mamma mi aveva costretto a indossare. Nel grande spazio aperto c’erano dieci coppie di scrivanie, separate da un vetro trasparente. Accanto a me non si voleva sedere nessuno. Avevano organizzato dei turni e io non vedevo l’ora che toccasse alla ragazza dalla grande bocca rosata che mi faceva tremare tutto. Più o meno ogni quattro settimane e mezzo, per cinque giorni, si metteva a lavorare a fianco a me. Annusavo il suo profumo e trovavo inebriante il sorriso aperto che mi regalava ogni mattina. Era l’unica a rivolgermi il saluto di buon giorno. Non riuscivo a distogliere lo sguardo da lei e ogni giorno contavo i suoi capelli, annotando su un foglio di carta il numero totale, che era sempre diverso. Quando la guardavo intensamente lei si ritraeva, e il suo sorriso si spegneva, per colpa dell’imbarazzo. Le avrei risparmiato quel fastidio, se non fosse che perdevo il controllo di me stesso e non potevo smettere di fissarla. Contare i suoi capelli era un bagno d’amore di cui era impossibile a fare a meno.
Oltre alle fotocopie appoggiavo quasi tutti i giorni sulla sua scrivania il cioccolatino che mi donava la mamma, rinunciando a pasticciarlo con le mani e a succhiarlo dai polpastrelli e dalle unghie. Ma la ragazza dalla grande bocca rosata gettava nel cestino entrambi i miei regali, senza aprirli. Lei pensava che non me ne accorgessi, invece io osservavo il mio cioccolatino in mezzo agli altri scarti e aspettavo il momento giusto per raccoglierlo di nascosto. Poi scappavo in bagno e lo masticavo insieme alle lacrime.
Continuavo a non capire perché tutto ciò che a me sembrava tenero fosse per loro oggetto di beffa. Poi un giorno, all’improvviso, è avvenuta la metamorfosi: le loro figure si sono trasfigurate e mi sono apparse con nasi adunchi, occhi iniettati di sangue, bocche senza labbra e denti affilati come belve, mani pelose con lunghi artigli, corpi massicci, schiene ricurve e arti superiori deformi. Per il terrore che mi incutevano ho perfezionato l’arte di scomparire. Camminavo raso muro e mi nascondevo sotto le scrivanie, cercando i miei ritagli dentro i cestini dei rifiuti.
Il vomitacarte ricicla i suoi scarti! Il vomitacarte si nutre di fogli! Il vomitacarte è completamente matto …
Non sono matto, pensavo, e intanto quelle voci sogghignanti mi rimbombavano nelle orecchie come versi satanici. Loro credevano che fossi innocuo, mentre io covavo la mia vendetta.
Ora mi trovo legato a questo letto e passo il tempo a osservare i contorni delle nuvole, annotando tutte quelle che riesco a contare in un giorno. Il nuovo palazzo di vetro è abbastanza simile al vecchio: le stanze sono tutte uguali e poche persone mi rivolgono la parola, ogni tanto, solo per qualche istante.
Come andiamo, Guido?
Bene.
Hai dormito stanotte?
Si.
Ecco il tuo bicchiere. Se prendi queste pillole starai bene fino a stasera.
Sto già bene.
Prendi le pillole, a più tardi.
Sono gli addetti e indossano un camice, bianco o verde, a seconda del loro grado di importanza. Pure qui c’è un grande capo, così mi pare di avere intuito. Ci sono anche persone senza camice: alcune sono legate ai letti, come me; altre parlano, cantano e ridono con se stesse. Nessuno ride di nessun altro.
Quando usciamo in giardino sono sempre accompagnato dal mio addetto con il camice bianco, il quale prima di slegarmi dal letto mi conficca un ago sul braccio e mi inietta un liquido che mi toglie le forze. In giardino conto le nuvole e posso finalmente dedicarmi al lavoro, sfogliando i quotidiani che mi procura l’addetto. Purtroppo devo fare tutto con le mani, perché mi hanno sequestrato le forbici. Mi costa fare a meno delle forbici.
Il mio nuovo capo indossa il camice verde. Legge sempre le cartelline che gli preparo e ne apprezza il contenuto.
Bravo Guido, stai facendo progressi.
Sto facendo progressi, confermo.
Ascolta, Guido. Qui c’è la tua vecchia cartellina, quella che hai lasciato sul tavolo del tuo capoufficio. Hai fatto bene a non distruggere il tuo lavoro. Mi sai dire perché hai scritto “andate all’inferno”, in fondo all’ultima pagina?
Non lo so, rispondo.
In verità lo so bene il motivo. E forse sa anche lui che li volevo ammazzare tutti. Allora perché me lo chiede?
Il capo con il camice verde mi dice spesso che sono fortunato: ho lavorato trent’anni al vecchio palazzo di vetro e quindi ho diritto a ricevere la grana. Prevede che prima o poi la mia famiglia utilizzerà la mia grana per farmi uscire da questo palazzo e garantirmi un’assistenza privata. Ma solo se dimostrerò un comportamento adeguato. Ho capito che adeguato significa non toccare le persone. Però non ho afferrato cosa sia esattamente la grana, soprattutto se abbia un altro significato, oltre a quello del famoso formaggio.
La mamma e i fratelli vengono spesso a farmi visita, ma non mi hanno mai parlato della grana, né dell’assistenza. Dicono solo che hanno chiesto al grande capo del nuovo palazzo di vetro il permesso di farmi trascorrere un giorno a casa. Scalpito di gioia al solo pensiero di sedermi a tavola con la mamma e i fratelli. Chissà se mi lasceranno dormire nel mio letto senza lacci addosso.
Arriva il giorno e mentre aspetto la mamma che mi viene a prendere non riesco a trattenere l’euforia, quindi saltello come un grillo e mi rosicchio le unghie. Di sicuro mi porterà un cioccolatino e lo terrò per ore tra le mani, guardandolo sciogliersi e leccando a poco a poco la polpa tra le dita.
La mamma però non arriva. Mi accompagnano l’addetto con il camice bianco e l’autista di un furgone che ci sta aspettando all’uscita del nuovo palazzo di vetro. Chiedo perché la mamma non è venuta a prendermi e il mio addetto mi dice che è per protezione. Non capisco da cosa debbano proteggermi, e intanto mi abbandono alla sensazione inebriante che mi provoca il liquido che mi hanno iniettato prima di farmi scendere dal letto.
A casa ci sono la mamma, i fratelli e altri parenti. Alcuni non li avevo mai visti prima di oggi. La tavola è imbandita e c’è anche un vassoio con del formaggio. Mi chiedo se si tratta della famosa grana. Ci sono i segnaposti, ma il mio nome non è segnato: io e l’addetto con il camice bianco mangiamo in cucina. I bambini si spaventerebbero se mi sedessi a tavola, oppure riderebbero di me e mi umilierebbero, mi spiega l’addetto. Tuttavia ascoltare le loro voci lontane mi fa sentire ancora più mortificato.
Tenerlo a casa? Non se ne parla… È pericoloso! Stava per ammazzare un uomo con la punta delle forbici. Era l’addetto alla sicurezza del suo ufficio. Lo ha fatto senza che vi fosse una ragione, almeno apparentemente. Forse si sentiva offeso perché lo chiamavano il vomitacarte. Capisco l’umiliazione, però ha esagerato. Si, ma ora farà ciò che deve? Lo spero.
Mi domando perché mi abbiano voluto a casa per un giorno se faccio ribrezzo anche ai bambini. Al ritorno lo chiederò al capo con il camice verde e gli dirò che dovevamo valutare insieme l’opportunità di questa mia visita. Non sto bene e vorrei tornare al nuovo palazzo di vetro.
Alla fine del pranzo la mamma e i fratelli arrivano in cucina e mi fanno firmare alcuni fogli che assomigliano a quelli appoggiati sulla scrivania del grande capo del vecchio palazzo di vetro. Mi stanno soffocando con il loro passeggiare avanti e indietro. Vogliono assicurarsi che io scriva il mio nome su ogni singola pagina. Girano i fogli e mi indicano dove va messa la firma.
Non mi è piaciuto questo ritorno a casa. Mi manca il grande capo con il camice verde e spero di tornare da lui il prima possibile, anche perché ho molte cose da chiedergli. Mi viene il sospetto che tutte queste firme abbiano a che fare con la grana e che la grana non sia un formaggio. Allora lo dico a voce alta, anzi lo urlo, mi alzo di scatto e li guardo con occhi minacciosi. Improvvisamente si trasformano anche loro in mostruose creature e allora sprigiono odio e simulo gesti aggressivi, pur avendo le mani legate. Mi piace l’idea che abbiano paura di me, così la smetteranno di guardarmi con dileggio, come se fossi un matto.
Faccio in tempo ad accorgermi che l’addetto con il camice bianco vorrebbe iniettarmi di nuovo il liquido che mi intontisce. Allora fingo di tornare calmo e saltello gioioso: osservo i bambini che ridono di me e gli adulti che brindano alle mie spalle.
Capisco che si sono fottuti i soldi, entro nel furgone che mi riporta al nuovo palazzo di vetro, guardo fuori dal finestrino e inizio a contare le nuvole.
Francesca Lococciolo, napoletana di nascita, cresciuta a Firenze, lavora a Roma da 22 anni in una grande azienda privata. Autrice di racconti pubblicati in antologie collettive, nel 2016 ha scritto il suo primo romanzo, intitolato “La verità muta” e pubblicato da Robin Edizioni. Con il racconto “Il vomitacarte” ha vinto nel 2015 l’ultima edizione del premio letterario “Una strada sbagliata”, dedicato a Fabrizio De Andrè.